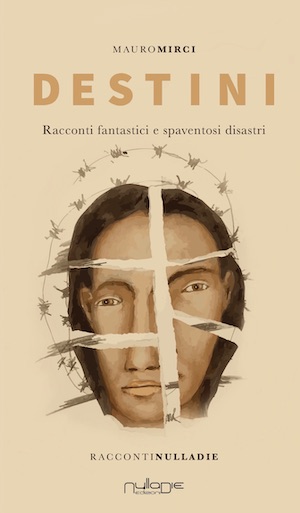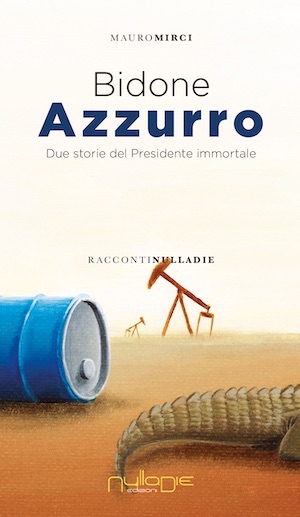Un’ennese fuori dal comune
Ricevo da Enzo Barnabà e volentieri pubblico, ma.mi. Ethan era gonfio fino all’inverosimile. Tutti i tessuti erano imbibiti dal liquido fuoruscito dal sangue. La pelle era macerata. Si stava decomponendo da vivo. Aveva addosso un vestito di lana a maglia, forse l’unico mai avuto. I fili si erano a poco… Continue reading